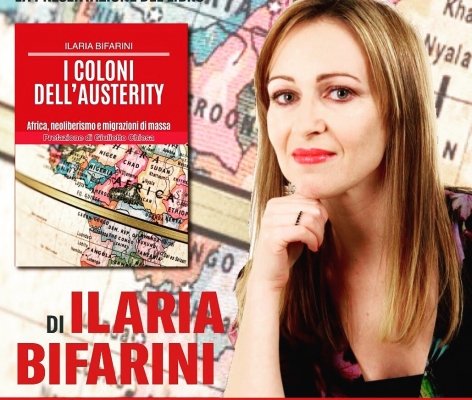Mercato del debito: zavorra per l’Africa
Segnalazione Arianna Editrice
di Mario Lettieri e Paolo Raimondi – 29/12/2024
Fonte: Mario Lettieri e Paolo Raimondi
Da quando il suo debito è negoziato sui mercati internazionali, il problema per l’Africa si è fatto più critico. Alla fine del 2023, il 49% del debito africano era in mano di privati, cioè di fondi, di banche e di altri finanzieri internazionali. Si prevede che salirà al 54% entro la fine del 2024. Tra il 2015 e il 2022, per 49 dei 54 paesi africani i costi medi del servizio del debito sono aumentati dall’8,4% al 12,7% del pil. Secondo l’African Economic Outlook Report della Banca africana per lo sviluppo (AfDB), nel 2024 i paesi africani dovrebbero spendere circa 74 miliardi di dollari per il servizio del debito. Rispetto ai 17 miliardi del 2010. 40 dei 74 miliardi è dovuto a creditori privati.
Il vicepresidente e capo economista dell’AfDB, Prof. Kevin Urama, intervenendo il 30 novembre alla quinta sessione straordinaria del Comitato per la finanza e gli affari monetari dell’Unione africana, tenutosi ad Abuja, in Nigeria, ha affermato: “La mutevole struttura del debito verso i creditori privati comporta opportunità e sfide. Quando prendono a prestito sui mercati dei capitali internazionali, i paesi africani pagano interessi del 500% in più rispetto a quanto pagherebbero all’AfDB e alla Banca mondiale”. Si tenga presente che dal 2010 il debito pubblico dell’Africa è aumentato del 170%, in gran parte a causa dei problemi strutturali del sistema debitorio, dei recenti shock globali e delle sue note debolezze.
Una delle ragioni dell’alto costo è certamente la tendenza di utilizzare debiti a breve termine e, quindi, a interesse alti, per finanziare progetti di sviluppo a lungo termine. Lo chiede il mercato. Le implicazioni per la sostenibilità del debito nel medio e lungo periodo sono ovvie. Come conseguenza, 20 paesi africani sono attualmente in difficoltà debitorie o ad alto rischio di esserlo, rispetto ai 13 del 2010.
Sempre secondo l’AfDB il rapporto debito pubblico/pil è mediamente cresciuto dal 54,5% del 2019 al 64% del 2020 per poi rimanere relativamente stabile. Dal 2000 al 2021 23 paesi africani hanno cercato crediti sui mercati privati per un totale di 1.510 miliardi di dollari. La stragrande maggioranza del debito pubblico verso l’estero è in dollari: nel 2022 circa il 70%, mentre quello in euro solo il 14,5%. Questa dipendenza dal dollaro è diventata nefasta quando la Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse. Molti paesi coprono i deficit di bilancio non pagando, ma rifinanziando i debiti in scadenza, soprattutto verso i fornitori privati di merci e di servizi e verso i creditori istituzionali. Il pagamento degli interessi sul debito rappresenta, mediamente per l’Africa nell’ultimo decennio, il 12,7% del pil, mentre la spesa per la salute solo 1,8% e quella per l’istruzione il 3,6 %.
Nel suo Regional Economic Outlook per l’Africa sub sahariana di ottobre, anche il Fondo monetario internazionale ha dipinto un quadro preoccupante: “L’inflazione rimane a due cifre in quasi un terzo dei paesi. La capacità di servizio del debito è bassa e l’aumento degli oneri debitori sta erodendo le risorse disponibili per lo sviluppo. Le riserve valutarie sono spesso insufficienti.”. I paesi esportatori di materie prime e di petrolio sarebbero in maggiori difficoltà.
Anche per tutte queste ragioni i leader africani chiedono riforme urgenti del sistema finanziario globale. Non vogliono essere le vittime delle speculazioni finanziarie e sulle commodity. Nello stesso tempo operano per un meccanismo di stabilità finanziaria regionale, per l’utilizzo delle monete locali nei commerci interafricani e, dove possibile, con il resto del mondo. In questo processo ci s’ispira alla Nuova Banca di sviluppo (Ndb) dei Brics.
Alla luce delle tensioni geopolitiche, dei rischi climatici e delle imprevedibili tendenze economiche globali, l’eccessiva dipendenza dell’Africa dai mercati esterni sta diventando sempre più problematica. L’AfDB enfatizza, perciò, la necessità di un sistema finanziario africano più solido e resiliente e di sforzi concertati per realizzare gli obiettivi d’integrazione economica a lungo termine del continente.
Molti paesi africani, tra cui la Nigeria, la più forte economia del continente, operano per stabilire istituzioni come l’African Monetary Institute e l’African Financing Stability Mechanism, sulla scia delle esperienze europee, che sono essenziali per raggiungere la convergenza macroeconomica, la resilienza finanziaria, l’indipendenza economica e l’autosufficienza del continente africano.
Queste problematiche economiche dei vari paesi africani non possono essere sottaciute o ignorate da chi – siano essi le amministrazioni americane, l’Ue e i vari paesi europei, a cominciare dall’Italia con il suo Piano Mattei – intende avere rapporti stabili con il continente. Si tratta in particolare di quei problemi finanziari strutturali globali che hanno ricadute nei paesi dell’Africa e del Sud del mondo. Sottovalutarli e non affrontarli vuol anche dire favorire un’incontrollata emigrazione di massa con i suoi effetti destabilizzanti.


 Patria e identità
Patria e identità